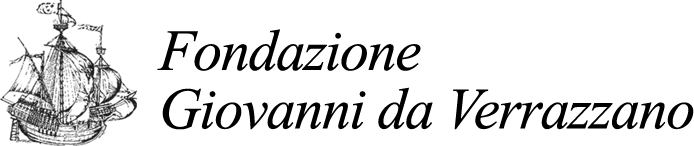Lettera da Giovanni da Verrazzano a Francesco I – luglio 1524
La lettera-relazione del luglio 1524 in cui il fiorentino Giovanni da Verrazzano informa Francesco I, Re di Francia, dei successi ottenuti nel suo viaggio d’esplorazione lungo la costa nordamericana (dalla Carolina del Sud alla Nuova Scozia).Dieppe, 8 luglio 1524
Serenissimo Re, Ora che sono tornato riferisco a Vostra Maestà quello che abbiamo scoperto. Partimmo il 17 gennaio 1524 da Deserta (Ilhas Desertas), un isolotto disabitato situato nei pressi dell’isola di Madera, con la Dalfina e un equipaggio di cinquanta uomini.
Avevamo viveri, armi e altri strumenti bellici e munizioni navali per resistere otto mesi. Prendemmo la rotta di ponente (ovest) con un leggero e soave vento che soffiava da levante (est) e percorremmo ottocento leghe (circa 4800 chilometri) in soli venticinque giorni. Il 24 febbraio, verso le ore 16, c’imbattemmo in una tempesta tanto violenta che credo nessun marinaio ne abbia mai vista una simile.
Solo con l’aiuto divino e grazie alla solidità della nave dal nome glorioso e dal destino fortunato e capace di resistere all’urto possente delle onde, riuscimmo a salvarci. Proseguimmo la nostra navigazione verso ponente, con una leggera deviazione verso nord. In altri venticinque giorni percorremmo più di quattrocento leghe (circa 2400 chilometri) e ci trovammo di fronte a una terra che non era mai stata vista da uomo antico o moderno.
Quando ci avvicinammo a un quarto di lega (circa un chilometro e mezzo) ci accorgemmo che era abitato per i grandissimi fuochi accesi sulla spiaggia. Ma non trovammo né un porto né un’insenatura per fermarci, e finimmo per gettare le ancore al largo, inviando a terra il battello. Scorgemmo molta gente che veniva sulla spiaggia ma quando vedevano che noi ci avvicinavamo, scappavano.
Cercammo di rassicurarli con gesti di vario tipo e alcuni di loro si avvicinarono esprimendo grande gioia nel vederci, mostrandosi sorpresi per i nostri abiti, per il nostro aspetto e per il colore della nostra carnagione. Scendemmo a terra e ciò che potemmo conoscere della loro vita e dei loro costumi lo dirò brevemente a Vostra Maestà. Vanno completamente nudi, ma si coprono i genitali con pelli di piccoli animali simili alle martore attaccate a una cintura d’erba stretta e ben intrecciata con code d’altri animali che, tutt’intorno al corpo, gli pendono fino alle ginocchia. Il resto del corpo lo tengono nudo e così pure la testa.
Qualcuno però porta ghirlande di piume d’uccello. Sono di colore bruno, non molto diversi dagli Etiopi (negri dell’Africa equatoriale). Hanno capelli neri e folti, non molto lunghi, che portano dietro la testa a forma di codino. Per quanto riguarda la loro figura, sono ben proporzionati, di statura media, qualche volta superiore alla nostra, con il torace ampio, le braccia robuste, le gambe e le altri parti del corpo ben strutturate. Hanno gli occhi neri e grandi, lo sguardo attento e vivace.
Non sono dotati di una grande forza fisica ma sono di intelligenza acuta e sono corridori agili e molto resistenti. Non ci fu possibile conoscere in maggior dettaglio la loro vita e i loro costumi perché rimanemmo a terra per breve tempo e perché eravamo sbarcati in pochi lasciando la nave ancorata al largo. Il litorale, tutto coperto di sabbia fine, s’innalza fino quindici piedi (circa un metro e mezzo) ed è largo una cinquantina di passi. Più oltre la terra appare ampia e dalla sua posizione elevata si affaccia sul litorale sabbioso con belle campagne e pianure ricoperte da grandissime foreste – in alcune zone rade, in altre folte – con alberi di così svariati colori, tanto belli e piacevoli a guardarsi, che è difficili dirlo a parole.
Questa terra è ricca di animali (cervi, daini, lepri e simili), di laghi e di stagni d’acqua viva con varie specie di uccelli adatti a soddisfare senza difficoltà tutti i dolci piaceri della cacciagione. L’aria è salubre, pura e temperata dal caldo e dal freddo. Il cielo è limpido e sereno, con piogge rare.
Lasciammo questa località continuando a seguire la costa che piegava di nuovo verso oriente (in direzione est-nord-est) e notammo sul litorale un numero grandissimo di fuochi e moltissima gente. Gettate le ancore al largo di quel litorale, perché non c’era un porto, fummo costretti a mandare a terra il battello con venticinque uomini per rifornirci d’acqua. Ma il mare, in quel tratto di spiaggia aperta, s’avventava contro la riva con onde gigantesche ed era impossibile far scendere qualcuno a terra senza correre il pericolo di perdere il battello. Intanto vedevamo molta gente accorrere sulla spiaggia rivolgendoci cenni d’amicizia e invitandoci e sbarcare.
In questa occasione ebbi modo di assistere a un episodio stupendo come Vostra Maestà avrà modo di capire. Mandammo a nuoto uno dei nostri giovani marinai per portare agli indigeni alcune cianfrusaglie, come sonagli, specchietti e piccoli oggetti d’ornamento.
Quando egli giunse a quattro braccia di distanza da loro gettò gli oggetti sulla spiaggia e fece per tornare indietro. Ma fu sbattuto da una ondata in maniera così violenta che cadde tramortito e venne trascinato a riva. Visto questo gli indigeni si precipitarono verso di lui e prendendolo per la testa, per le gambe e per le braccia lo portarono un po’ lontano. Vedendosi trasportare in quel modo, il giovane, terrorizzato, lanciava grandissime urla. Ed essi facevano lo stesso nella loro lingua, facendogli segno di calmarsi e tranquillizzarsi. Poi lo adagiarono per terra, al sole, ai piedi d’una piccola collina e cominciarono a fare grandi gesti di meraviglia. Osservarono con stupore la carnagione bianca, lo squadrarono per bene, gli tolsero la camicia e i pantaloni.
Dopo averlo spogliato accesero un grande fuoco e lo avvicinarono alle fiamme. Vedendo questo i marinai che erano rimasti sul battello si spaventarono molto – come succede sempre a essi di fronte a ogni novità – e pensarono che gli indigeni lo volessero arrostire per mangiarselo.
Il marinaio, nel frattempo, si era ripreso e dopo essere rimasto per qualche tempo in mezzo agli indigeni, a segni fece loro capire di voler tornare alla nave. Ed essi esprimendogli molto affetto continuando a toccarlo e ad abbracciarlo lo accompagnarono fino al mare e per essere più tranquilli salirono su un alto colle e lo seguirono con lo sguardo fino a quando egli non salì sul battello.
Essi sono di colore nero come gli altri (che abbiamo conosciuto prima) hanno la pelle molto lucida e sono di statura media. Dimostrano poca forza ma un’intelligenza sveglia. Partiti da qui, seguendo sempre la costa che si spostava parecchio in direzione nord, giungemmo, dopo 50 leghe (circa 300 chilometri), a un’altra terra che sembrava molto più bella e ricoperta di grandissime foreste in cui gettammo le ancore. Venti di noi ci inoltrammo all’interno per circa due leghe (12 chilometri) e ci accorgemmo che la gente si era nascosta nella foresta.
Questi indigeni ci sembrarono di carnagione più chiara di quelli visti fino ad allora. Si vestono con certe erbe che penzolano dai rami degli alberi e che essi intrecciano con varie corde di canapa silvestre. Vanno a testa scoperta come gli altri. Si nutrono in prevalenza di legumi gustosissimi (fagioli), ne hanno in abbondanza e di tipi diversi, per colore e grandezza, di quelli in uso da noi. Praticano, inoltre, la pesca di pesci e uccelli, catturandoli con archi e lacciuoli. Costruiscono gli archi di legno duro e le frecce di canna, collocando all’estremità ossi di pesci e di altri animali. In quella regione gli animali sono più feroci che in Europa, perché sono continuamente molestati dai cacciatori. Vedemmo molte delle loro barchette costruite con il tronco di un solo albero, lunghe venti piedi (6 metri), larghe quattro (1,20 metri).
Nel costruirle non usano né pietre, né ferro o altri metalli. In questa terra che noi abbiamo percorso per duecento leghe (1200 chilometri) non abbiamo mai visto neppure una pietra. Si aiutano con il fuoco bruciando del fusto dell’albero solo quanto basta a creare la concavità della barca, e usano lo stesso procedimento per fare la prua e la poppa in modo che l’imbarcazione navigando possa solcare le onde del mare.
La terra per conformazione, fertilità e bellezza è come l’altra. Le foreste sono poco folte e piene di alberi di vario genere ma non particolarmente aromatici perché la regione è più settentrionale e fredda. Notammo molte viti selvatiche che crescendo si abbarbicano agli alberi come fanno nell’Italia settentrionale. Se queste viti fossero coltivate come si deve certamente produrrebbero ottimi vini perché più volte ne ho assaggiato il frutto e l’ho trovato soave e dolce. Per gli indigeni le viti sono importanti, tanto è vero che dovunque esse nascono gli tolgono l’erbaccia tutt’intorno per facilitarne la germinazione.
Trovammo rose selvatiche, viole, gigli e moti tipi di erbe e di fiori aromatici diversi dai nostri. Non avemmo modo di conoscere le loro case perché erano situate nell’entroterra. Pensiamo da molti segni che vedemmo che esse siano fatte di legno e di fibre vegetali. Così pure riteniamo, sulla base di una serie di indizi e di indicazioni, che molti di essi dormano all’aperto. Pensiamo che anche tutti gli altri indigeni delle terre viste prima vivano allo stesso modo. Rimanemmo tre giorni in questo posto con le ancore calate al largo per mancanza di porti nella zona. Decidemmo, quindi, di riprendere la navigazione lungo la costa (che battezzammo Arcadia per la bellezza degli alberi) seguendo una rotta di nord-est.
Ci muovevamo solo di giorno e al calar della notte gettavamo le ancore. La zona era molto verde e boscosa, ma senza porti. Si scorgevano, di tanto in tanto, bei promontori e piccoli corsi d’acqua. Trovammo un uomo che si avvicinava alla spiaggia per vedere che gente eravamo. Era guardingo e sospettoso. Ci osservava, ma non permetteva che ci accostassimo a lui (allontanandosi se lo facevamo).
Era bello, nudo, con i capelli riuniti a nodo e di colore olivastro. Noi a terra eravamo in venti e a forza di lusinghe riuscimmo a farlo avvicinare fino a circa due braccia e ci faceva vedere un legno acceso come per farci dono del fuoco. Noi, da parte nostra, facemmo fuoco di polvere con l’acciarino e lui tremò tutto di paura. Tirammo una carica di schioppo: restò come impietrito e pregò, predicando come un frate. Indicando con il dito il cielo e guardando la nave e il mare pareva che ci volesse benedire. Dopo cento leghe (600 chilometri) incontrammo una località molto bella, situata fra due colline in mezzo alle quali scorreva, verso il mare, un grandissimo fiume. Entrammo nel fiume con il battello e scendemmo a terra.
La trovammo molto popolata. Gli indigeni erano d’aspetto simili agli altri (che avevamo conosciuto). Vestiti con penne di uccelli di vari colori, ci venivano incontro allegramente emettendo grandi grida di meraviglia e indicandoci il posto migliore per attraccare con il battello. Arrivammo, quindi, a un’altra isola, a 15 leghe di distanza (90 chilometri) dove trovammo una bellissima insenatura. Prima di entrarvi vedemmo una ventina di barche piene di gente che lanciando grida di meraviglia circondavano la nave. Non si accostarono a meno di cinquanta passi, e, fermatisi, guardavano l’imbarcazione, il nostro aspetto e i vestiti (che indossavamo). Poi tutti insieme lanciarono un urlo per mostrare la loro contentezza (nel vederci). Riuscimmo a rassicurarli un po’ imitando i loro gesti e allora si avvicinarono tanto che potemmo lanciargli sonagli, specchietti e cianfrusaglie varie.
Essi li presero, li guardarono ridendo e senza più paura salirono a bordo della nave. Tra di loro c’erano due re di aspetto così bello e vigoroso che è difficile farne la descrizione. Il primo aveva circa quarant’anni; l’altro era un giovane di ventiquattro anni. Vestivano tutti e due alla stessa maniera. Il più anziano sul corpo nudo indossava una pelle di cervo lavorata come i tessuti di Damasco, con vari ricami. Non portava niente sulla testa e i capelli li aveva riuniti e legati dietro la nuca con diversi tipi di legature. Al collo portava una larga catena ornata di pietre di diverso colore. L’abbigliamento del giovane era simile. Questa è la gente più bella e di costumi più miti che abbiamo trovato in tutto il viaggio. Di statura sono più alti di noi, sono di colore del bronzo ma alcuni tendono più al bianco e altri al giallo. Il volto è affilato, i capelli sono lunghi e neri ed essi li curano moltissimo, gli occhi sono neri e guizzanti, l’aspetto è dolce e soave alla maniera degli antichi. (Imitando la compostezza delle statue classiche). Le loro donne sono altrettanto belle e ben formate, molto gentili, eleganti, di aspetto gradevole.
I loro costumi e la loro continenza femminile sono quanto di meglio si può chiedere a una creatura umana. Vanno nude con addosso solo una pelle di cervo ricamata, come gli uomini. Alcune di esse alle braccia portano preziose pelli di lince. Portano il capo scoperto con i capelli fratti a trecce che gli pendono ai due lati del petto. Le donne adulte e sposate portano acconciature simili a quelle che usano le donne in Egitto e in Siria. Alle orecchie portano pendenti di ogni tipo, alla maniera orientale, e questo sia gli uomini che le donne. Tra l’altro notammo molte lamine di rame lavorate che essi stimano più dell’oro.
Quest’ultimo non è apprezzato per via del colore. Tra tutti i metalli, anzi, l’oro è quello di minor valore perché di colore giallo e il giallo lo aborriscono. I colori più amati sono l’azzurro e il rosso. Delle cose che noi regalavamo loro apprezzarono di più i sonagli, i cristallini azzurri e altri ninnoli da mettere alle orecchie e al collo.
Serenissimo Re, Ora che sono tornato riferisco a Vostra Maestà quello che abbiamo scoperto. Partimmo il 17 gennaio 1524 da Deserta (Ilhas Desertas), un isolotto disabitato situato nei pressi dell’isola di Madera, con la Dalfina e un equipaggio di cinquanta uomini.
Avevamo viveri, armi e altri strumenti bellici e munizioni navali per resistere otto mesi. Prendemmo la rotta di ponente (ovest) con un leggero e soave vento che soffiava da levante (est) e percorremmo ottocento leghe (circa 4800 chilometri) in soli venticinque giorni. Il 24 febbraio, verso le ore 16, c’imbattemmo in una tempesta tanto violenta che credo nessun marinaio ne abbia mai vista una simile.
Solo con l’aiuto divino e grazie alla solidità della nave dal nome glorioso e dal destino fortunato e capace di resistere all’urto possente delle onde, riuscimmo a salvarci. Proseguimmo la nostra navigazione verso ponente, con una leggera deviazione verso nord. In altri venticinque giorni percorremmo più di quattrocento leghe (circa 2400 chilometri) e ci trovammo di fronte a una terra che non era mai stata vista da uomo antico o moderno.
Quando ci avvicinammo a un quarto di lega (circa un chilometro e mezzo) ci accorgemmo che era abitato per i grandissimi fuochi accesi sulla spiaggia. Ma non trovammo né un porto né un’insenatura per fermarci, e finimmo per gettare le ancore al largo, inviando a terra il battello. Scorgemmo molta gente che veniva sulla spiaggia ma quando vedevano che noi ci avvicinavamo, scappavano.
Cercammo di rassicurarli con gesti di vario tipo e alcuni di loro si avvicinarono esprimendo grande gioia nel vederci, mostrandosi sorpresi per i nostri abiti, per il nostro aspetto e per il colore della nostra carnagione. Scendemmo a terra e ciò che potemmo conoscere della loro vita e dei loro costumi lo dirò brevemente a Vostra Maestà. Vanno completamente nudi, ma si coprono i genitali con pelli di piccoli animali simili alle martore attaccate a una cintura d’erba stretta e ben intrecciata con code d’altri animali che, tutt’intorno al corpo, gli pendono fino alle ginocchia. Il resto del corpo lo tengono nudo e così pure la testa.
Qualcuno però porta ghirlande di piume d’uccello. Sono di colore bruno, non molto diversi dagli Etiopi (negri dell’Africa equatoriale). Hanno capelli neri e folti, non molto lunghi, che portano dietro la testa a forma di codino. Per quanto riguarda la loro figura, sono ben proporzionati, di statura media, qualche volta superiore alla nostra, con il torace ampio, le braccia robuste, le gambe e le altri parti del corpo ben strutturate. Hanno gli occhi neri e grandi, lo sguardo attento e vivace.
Non sono dotati di una grande forza fisica ma sono di intelligenza acuta e sono corridori agili e molto resistenti. Non ci fu possibile conoscere in maggior dettaglio la loro vita e i loro costumi perché rimanemmo a terra per breve tempo e perché eravamo sbarcati in pochi lasciando la nave ancorata al largo. Il litorale, tutto coperto di sabbia fine, s’innalza fino quindici piedi (circa un metro e mezzo) ed è largo una cinquantina di passi. Più oltre la terra appare ampia e dalla sua posizione elevata si affaccia sul litorale sabbioso con belle campagne e pianure ricoperte da grandissime foreste – in alcune zone rade, in altre folte – con alberi di così svariati colori, tanto belli e piacevoli a guardarsi, che è difficili dirlo a parole.
Questa terra è ricca di animali (cervi, daini, lepri e simili), di laghi e di stagni d’acqua viva con varie specie di uccelli adatti a soddisfare senza difficoltà tutti i dolci piaceri della cacciagione. L’aria è salubre, pura e temperata dal caldo e dal freddo. Il cielo è limpido e sereno, con piogge rare.
Lasciammo questa località continuando a seguire la costa che piegava di nuovo verso oriente (in direzione est-nord-est) e notammo sul litorale un numero grandissimo di fuochi e moltissima gente. Gettate le ancore al largo di quel litorale, perché non c’era un porto, fummo costretti a mandare a terra il battello con venticinque uomini per rifornirci d’acqua. Ma il mare, in quel tratto di spiaggia aperta, s’avventava contro la riva con onde gigantesche ed era impossibile far scendere qualcuno a terra senza correre il pericolo di perdere il battello. Intanto vedevamo molta gente accorrere sulla spiaggia rivolgendoci cenni d’amicizia e invitandoci e sbarcare.
In questa occasione ebbi modo di assistere a un episodio stupendo come Vostra Maestà avrà modo di capire. Mandammo a nuoto uno dei nostri giovani marinai per portare agli indigeni alcune cianfrusaglie, come sonagli, specchietti e piccoli oggetti d’ornamento.
Quando egli giunse a quattro braccia di distanza da loro gettò gli oggetti sulla spiaggia e fece per tornare indietro. Ma fu sbattuto da una ondata in maniera così violenta che cadde tramortito e venne trascinato a riva. Visto questo gli indigeni si precipitarono verso di lui e prendendolo per la testa, per le gambe e per le braccia lo portarono un po’ lontano. Vedendosi trasportare in quel modo, il giovane, terrorizzato, lanciava grandissime urla. Ed essi facevano lo stesso nella loro lingua, facendogli segno di calmarsi e tranquillizzarsi. Poi lo adagiarono per terra, al sole, ai piedi d’una piccola collina e cominciarono a fare grandi gesti di meraviglia. Osservarono con stupore la carnagione bianca, lo squadrarono per bene, gli tolsero la camicia e i pantaloni.
Dopo averlo spogliato accesero un grande fuoco e lo avvicinarono alle fiamme. Vedendo questo i marinai che erano rimasti sul battello si spaventarono molto – come succede sempre a essi di fronte a ogni novità – e pensarono che gli indigeni lo volessero arrostire per mangiarselo.
Il marinaio, nel frattempo, si era ripreso e dopo essere rimasto per qualche tempo in mezzo agli indigeni, a segni fece loro capire di voler tornare alla nave. Ed essi esprimendogli molto affetto continuando a toccarlo e ad abbracciarlo lo accompagnarono fino al mare e per essere più tranquilli salirono su un alto colle e lo seguirono con lo sguardo fino a quando egli non salì sul battello.
Essi sono di colore nero come gli altri (che abbiamo conosciuto prima) hanno la pelle molto lucida e sono di statura media. Dimostrano poca forza ma un’intelligenza sveglia. Partiti da qui, seguendo sempre la costa che si spostava parecchio in direzione nord, giungemmo, dopo 50 leghe (circa 300 chilometri), a un’altra terra che sembrava molto più bella e ricoperta di grandissime foreste in cui gettammo le ancore. Venti di noi ci inoltrammo all’interno per circa due leghe (12 chilometri) e ci accorgemmo che la gente si era nascosta nella foresta.
Questi indigeni ci sembrarono di carnagione più chiara di quelli visti fino ad allora. Si vestono con certe erbe che penzolano dai rami degli alberi e che essi intrecciano con varie corde di canapa silvestre. Vanno a testa scoperta come gli altri. Si nutrono in prevalenza di legumi gustosissimi (fagioli), ne hanno in abbondanza e di tipi diversi, per colore e grandezza, di quelli in uso da noi. Praticano, inoltre, la pesca di pesci e uccelli, catturandoli con archi e lacciuoli. Costruiscono gli archi di legno duro e le frecce di canna, collocando all’estremità ossi di pesci e di altri animali. In quella regione gli animali sono più feroci che in Europa, perché sono continuamente molestati dai cacciatori. Vedemmo molte delle loro barchette costruite con il tronco di un solo albero, lunghe venti piedi (6 metri), larghe quattro (1,20 metri).
Nel costruirle non usano né pietre, né ferro o altri metalli. In questa terra che noi abbiamo percorso per duecento leghe (1200 chilometri) non abbiamo mai visto neppure una pietra. Si aiutano con il fuoco bruciando del fusto dell’albero solo quanto basta a creare la concavità della barca, e usano lo stesso procedimento per fare la prua e la poppa in modo che l’imbarcazione navigando possa solcare le onde del mare.
La terra per conformazione, fertilità e bellezza è come l’altra. Le foreste sono poco folte e piene di alberi di vario genere ma non particolarmente aromatici perché la regione è più settentrionale e fredda. Notammo molte viti selvatiche che crescendo si abbarbicano agli alberi come fanno nell’Italia settentrionale. Se queste viti fossero coltivate come si deve certamente produrrebbero ottimi vini perché più volte ne ho assaggiato il frutto e l’ho trovato soave e dolce. Per gli indigeni le viti sono importanti, tanto è vero che dovunque esse nascono gli tolgono l’erbaccia tutt’intorno per facilitarne la germinazione.
Trovammo rose selvatiche, viole, gigli e moti tipi di erbe e di fiori aromatici diversi dai nostri. Non avemmo modo di conoscere le loro case perché erano situate nell’entroterra. Pensiamo da molti segni che vedemmo che esse siano fatte di legno e di fibre vegetali. Così pure riteniamo, sulla base di una serie di indizi e di indicazioni, che molti di essi dormano all’aperto. Pensiamo che anche tutti gli altri indigeni delle terre viste prima vivano allo stesso modo. Rimanemmo tre giorni in questo posto con le ancore calate al largo per mancanza di porti nella zona. Decidemmo, quindi, di riprendere la navigazione lungo la costa (che battezzammo Arcadia per la bellezza degli alberi) seguendo una rotta di nord-est.
Ci muovevamo solo di giorno e al calar della notte gettavamo le ancore. La zona era molto verde e boscosa, ma senza porti. Si scorgevano, di tanto in tanto, bei promontori e piccoli corsi d’acqua. Trovammo un uomo che si avvicinava alla spiaggia per vedere che gente eravamo. Era guardingo e sospettoso. Ci osservava, ma non permetteva che ci accostassimo a lui (allontanandosi se lo facevamo).
Era bello, nudo, con i capelli riuniti a nodo e di colore olivastro. Noi a terra eravamo in venti e a forza di lusinghe riuscimmo a farlo avvicinare fino a circa due braccia e ci faceva vedere un legno acceso come per farci dono del fuoco. Noi, da parte nostra, facemmo fuoco di polvere con l’acciarino e lui tremò tutto di paura. Tirammo una carica di schioppo: restò come impietrito e pregò, predicando come un frate. Indicando con il dito il cielo e guardando la nave e il mare pareva che ci volesse benedire. Dopo cento leghe (600 chilometri) incontrammo una località molto bella, situata fra due colline in mezzo alle quali scorreva, verso il mare, un grandissimo fiume. Entrammo nel fiume con il battello e scendemmo a terra.
La trovammo molto popolata. Gli indigeni erano d’aspetto simili agli altri (che avevamo conosciuto). Vestiti con penne di uccelli di vari colori, ci venivano incontro allegramente emettendo grandi grida di meraviglia e indicandoci il posto migliore per attraccare con il battello. Arrivammo, quindi, a un’altra isola, a 15 leghe di distanza (90 chilometri) dove trovammo una bellissima insenatura. Prima di entrarvi vedemmo una ventina di barche piene di gente che lanciando grida di meraviglia circondavano la nave. Non si accostarono a meno di cinquanta passi, e, fermatisi, guardavano l’imbarcazione, il nostro aspetto e i vestiti (che indossavamo). Poi tutti insieme lanciarono un urlo per mostrare la loro contentezza (nel vederci). Riuscimmo a rassicurarli un po’ imitando i loro gesti e allora si avvicinarono tanto che potemmo lanciargli sonagli, specchietti e cianfrusaglie varie.
Essi li presero, li guardarono ridendo e senza più paura salirono a bordo della nave. Tra di loro c’erano due re di aspetto così bello e vigoroso che è difficile farne la descrizione. Il primo aveva circa quarant’anni; l’altro era un giovane di ventiquattro anni. Vestivano tutti e due alla stessa maniera. Il più anziano sul corpo nudo indossava una pelle di cervo lavorata come i tessuti di Damasco, con vari ricami. Non portava niente sulla testa e i capelli li aveva riuniti e legati dietro la nuca con diversi tipi di legature. Al collo portava una larga catena ornata di pietre di diverso colore. L’abbigliamento del giovane era simile. Questa è la gente più bella e di costumi più miti che abbiamo trovato in tutto il viaggio. Di statura sono più alti di noi, sono di colore del bronzo ma alcuni tendono più al bianco e altri al giallo. Il volto è affilato, i capelli sono lunghi e neri ed essi li curano moltissimo, gli occhi sono neri e guizzanti, l’aspetto è dolce e soave alla maniera degli antichi. (Imitando la compostezza delle statue classiche). Le loro donne sono altrettanto belle e ben formate, molto gentili, eleganti, di aspetto gradevole.
I loro costumi e la loro continenza femminile sono quanto di meglio si può chiedere a una creatura umana. Vanno nude con addosso solo una pelle di cervo ricamata, come gli uomini. Alcune di esse alle braccia portano preziose pelli di lince. Portano il capo scoperto con i capelli fratti a trecce che gli pendono ai due lati del petto. Le donne adulte e sposate portano acconciature simili a quelle che usano le donne in Egitto e in Siria. Alle orecchie portano pendenti di ogni tipo, alla maniera orientale, e questo sia gli uomini che le donne. Tra l’altro notammo molte lamine di rame lavorate che essi stimano più dell’oro.
Quest’ultimo non è apprezzato per via del colore. Tra tutti i metalli, anzi, l’oro è quello di minor valore perché di colore giallo e il giallo lo aborriscono. I colori più amati sono l’azzurro e il rosso. Delle cose che noi regalavamo loro apprezzarono di più i sonagli, i cristallini azzurri e altri ninnoli da mettere alle orecchie e al collo.
Non mostravano interesse per i drappi di seta e di oro, né di altro tipo, né gli importava di averli. La stessa cosa succedeva con i metalli come acciaio e ferro: più volte gli facemmo vedere le nostre armi ma non mostravano interesse per esse né le chiedevano. Si limitavano ad ammirarne l’ingegnosità dell’esecuzione. Facevano la stessa cosa con gli specchi: li guardavano un attimo e ridendo li restituivano. Sono molto generosi. Tutto quello che hanno sono disposti a darlo. Stringemmo con loro una forte amicizia. Un giorno prima che entrassimo con la nave nell’insenatura fummo costretti per via del tempo cattivo a gettare l’ancora al largo a una lega (6 chilometri) dalla costa. Allora essi vennero con un gran numero di barche sotto la nave. Avevano i volti dipinti e imbrattati di vari colori e si mostravano allegri e contenti. Ci portarono i loro cibi e ci indicarono dove dovevamo gettare l’ancora, nel porto, per mettere al sicuro la nave. Ci accompagnarono con le barche e rimasero con noi fino a quando non calammo l’ancora. In quest’insenatura rimanemmo quindici giorni, rifornendoci delle cose di cui avevamo bisogno. E ogni giorno venivano indigeni a vedere la nave portando con sé le loro donne. Di esse sono molto gelosi. Quando salivano a bordo della nave, anche se vi restavano a lungo, facevano aspettare le donne nelle barche. Li pregammo in tutte le maniere promettendogli regali di ogni tipo, ma non le fecero salire a bordo. Ci recammo più volte nell’interno, per cinque o sei leghe (30 e 36 chilometri), e trovammo la terra di una bellezza indescrivibile e adatta a ogni genere di colture: frumento, vino olio; perché in esse ci sono campagne larghe da venticinque a trenta leghe (150-180 chilometri) aperte e senza alcun impedimento di alberi e di una tale fertilità che qualsiasi seme darebbe un ottimo frutto.
Quanto alle foreste, esse in un modo o nell’altro, possono essere tutte attraversate anche da un esercito numeroso. Nelle foreste crescono querce, cipressi e altri alberi sconosciuti in Europa. Trovammo ciliegi, prugni, noccioli e molti tipi di frutta diversi dai nostri. Animali ce ne sono moltissimi: cervi, daini, linci e altre specie che essi catturano – come gli altri indigeni – con archi e lacciuoli, che costituiscono per essi le armi principali. Le loro frecce sono lavorate con grande abilità, mettendo nella punta, al posto del ferro, smeriglio, diaspro, marmo duro e altre pietre taglienti. Di queste si servono al posto del ferro per tagliare alberi e costruire le loro barche da un solo fusto di legno. Con grande maestria essi ricavano dal fusto una superficie concava in cui possono trovare posto comodamente da quattordici a quindici persone. Hanno un remo corto che s’allarga in punta e di cui si servono in mare ricorrendo solo alla forza delle braccia, senza alcun pericolo e imprimendo alla barca tutta la velocità che vogliono. Penetrando nell’interno vedemmo le loro case. Sono costruite in forma circolare con una grandezza di quattordici o quindici passi sovrapponendo semplicemente alberi piegati a semicerchio e coprendoli con stuoie di paglia abilmente intrecciate che li riparano dal freddo e dalla pioggia. Non c’è dubbio che, se essi avessero attrezzi perfezionati come quelli che noi abbiamo, costruirebbero edifici magnifici.
Tutto il litorale è pieno di pietre cerulee, cristalline e d’alabastro, ed è per questo che esso è pieno di insenature e luoghi di riparo per le imbarcazioni. Spostano le case da una località all’altra a seconda della fertilità del terreno e a seconda del tempo che sono rimasti in un posto. Portano via solo le stuoie di copertura e all’istante hanno le nuove abitazioni belle e pronte. In ogni casa vivono il padre con la sua famiglia che può essere numerosissima. In alcune abitazioni contammo da venticinque a trenta persone. Si cibano soprattutto di legumi, come gli altri indigeni. Ma essi li producono con tecniche di coltura più raffinate, tendendo presente l’influsso lunare dei semi, la nascita delle Pleiadi e molti altri elementi indicati dagli antichi. Importanti per la loro alimentazione sono anche la cacciagione e i pesci. Vivono a lungo e raramente cadono malati. Se sono feriti, senza gemiti, si curano da soli con il fuoco. Pensiamo che perlopiù muoiano di vecchiaia. Hanno uno spiccato senso della compassione e della generosità nei riguardi del loro prossimo. Nelle disgrazie si profondono in lamenti e nelle avversità si ricordano di tutti i momenti felici. Quando muore un parente ricorrono al Pianto siciliano misto a canto, prolungandolo per molto tempo. Questo è quanto potemmo conoscere di loro. Cinquanta leghe (300 chilometri) dopo, spostandoci più a nord, scoprimmo una terra montagnosa, piena di foreste molto folte formate da abeti, cipressi (abeti canadesi) e altri alberi del genere che crescono nelle regioni fredde. Gli abitanti della zona erano diversi da tutti gli altri: se quelli erano di modi e comportamenti gentili, questi, invece, erano pieni di crudeltà e cattive abitudini, tanto selvaggi che non riuscimmo mai, per quanti segni facessimo, ad avviare una conversazione con loro. Indossano pelli d’orso, di lince, lupo marino e d’altri animali, si cibano, per quello che potemmo sapere visitando più volte le loro case, di cacciagione, di pesci e di alcuni frutti che sono una specie di radici prodotte spontaneamente dalla terra. Non hanno legumi, né vedemmo alcun segno di coltivazioni. E del resto la terra, a causa della sua sterilità, non potrebbe dare nessun seme o frutto. Se qualche volta accettavano di barattare le loro cose con le nostre si mettevano su un punto scoglioso del litorale dove più violentemente si infrangeva il flutto del mare.
E mentre noi stavano nel battello con una corda ci tiravano quello che ci volevano dare gridando di continuo che non ci avvicinassimo a terra e che dessimo subito la roba in cambio. Delle nostre cose accettavano soltanto coltelli, armi da pesca e metalli taglienti. Non davano nessuna importanza agli ornamenti. Quando non avevamo più niente da barattare, senza che noi li provocassimo gli uomini ci facevano tutti i gesti dispregiativi e disonorevoli che può fare una persona scostumata, come mostrare il culo, e scoppiavano a ridere. La terra dove essi abitano si trova a latitudine 43 e 2/3. Contro la loro volontà scendemmo a terra con venticinque uomini armati, e ci inoltrammo nell’interno per due o tre leghe (12-18 chilometri).
Quando sbarcavamo ci scagliavano frecce con gli archi lanciando grandi urla e poi fuggivano nelle foreste. Non individuammo in questa terra prodotto di alcun interesse a parte le grandissime foreste. Alcune colline potrebbero contenere metalli. Infatti a molti vedemmo grossi grani di rame nelle orecchie. Partimmo seguendo la costa in direzione di nord-est, che ci apparve la più bella, aperta e priva di foreste, con alte montagne nell’entroterra che si abbassavano gradualmente verso il litorale. In un tratto di cinquanta leghe (300 chilometri) scoprimmo 32 isole.
Le tre più grandi le chiamammo Le tre figlie di Navarra e tutte erano in prossimità del continente, piccole e di bello aspetto, montagnose e allineate alla terraferma, tra le quali si formavano magnifici porti e canali come nel golfo Adriatico, nell’Illiria e nella Dalmazia. Non avemmo contatto con gli abitanti, ma pensiamo che non siano diversi dagli altri per aspetto fisico e costumi. Navigando tra subsulano (levante o est) e aquilone (nord) dopo aver percorso centocinquanta leghe (900 chilometri) arrivammo vicini alla terra scoperta in passato dai Britannici che è situata alla latitudine di cinquanta gradi.
Trovandoci a corto di attrezzature navali e di viveri, dopo aver scoperto settecento e più leghe (oltre 4200 chilometri) di nuove terre, ci rifornimmo di acqua e di legna e decidemmo di rientrare in Francia. Quanto alla fede che professano tutte questi popoli che abbiamo scoperto per la differenza di linguaggio non siamo riusciti a farcene un’idea, né ci sono serviti a questo scopo i segni e i gesti. Pensammo che non avessero nessuna fede o legge; che non conoscessero una prima causa o motore; che non venerassero il cielo, le stelle, il sole o la luna o altri pianeti; e che non praticassero neanche qualche tipo di idolatria. Né ci risultò che essi facessero sacrifici o altri atti di culto o che nei loro villaggi ci fossero templi e chiese per pregare. Pensiamo che non professino nessuna fede e che vivano in totale libertà.
E tutto ha come causa l’ignoranza: perché è molto facile persuaderli e tutto ciò che – in fatto di culto divino – vedevano fare a noi cristiani essi lo facevano pure, con lo stesso zelo e l’entusiasmo nostro.
Dalla nave Dal fina, dì 8 di luglio 1524. Humilis servitor Ianus Verazanus.
A Leonardo Tedaldi o a Tomaso Sartini, mercanti in Leone.
Mandaretelo a Bonacorso Ruscelli.